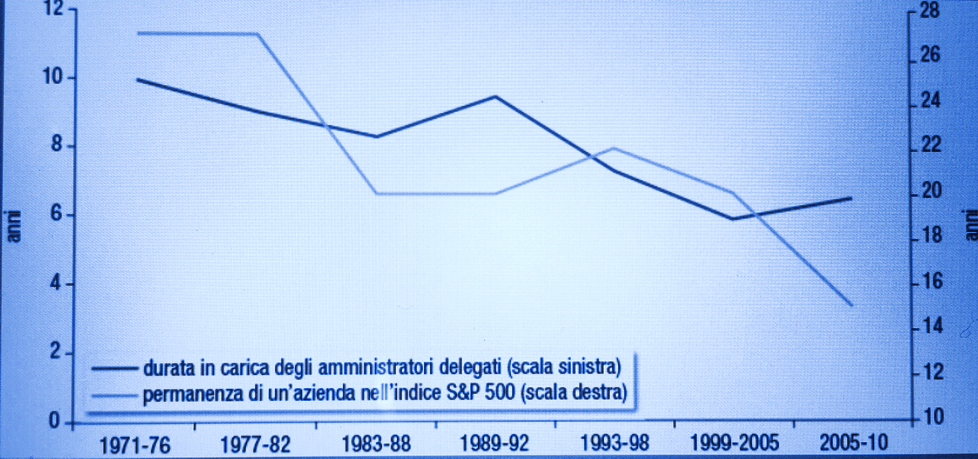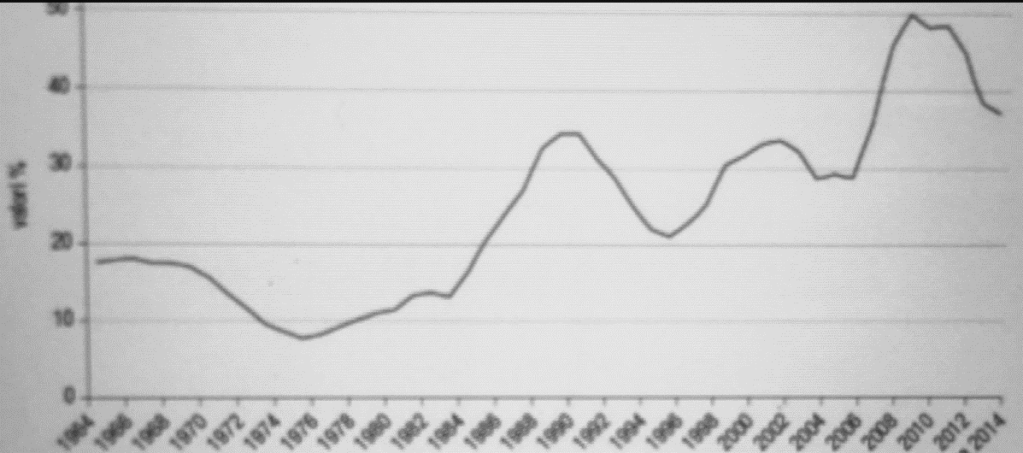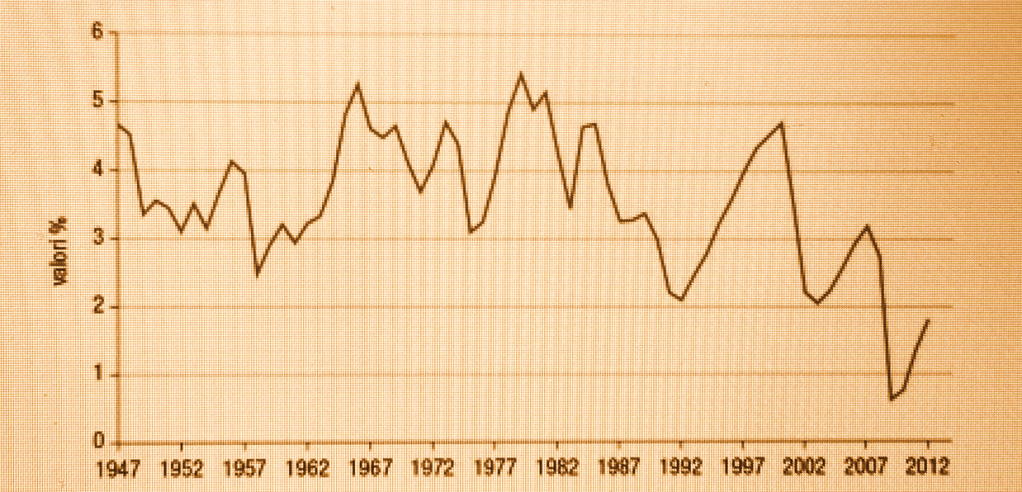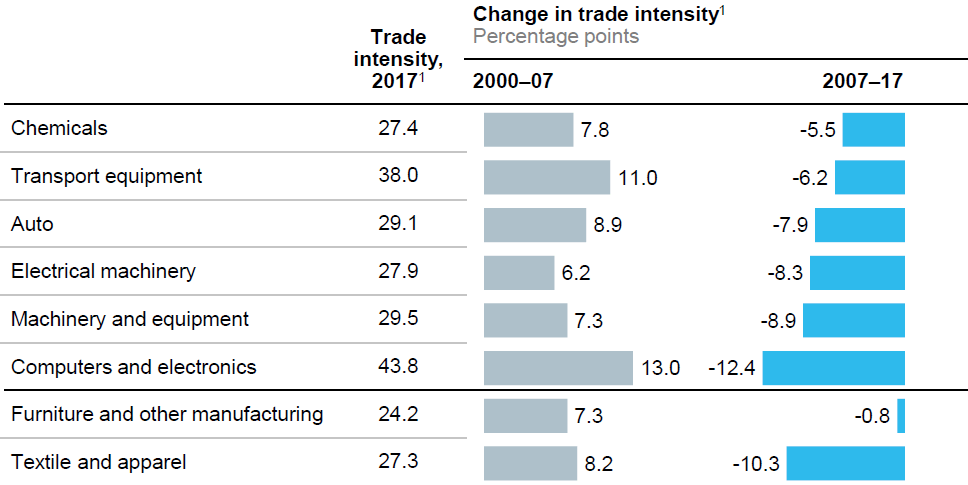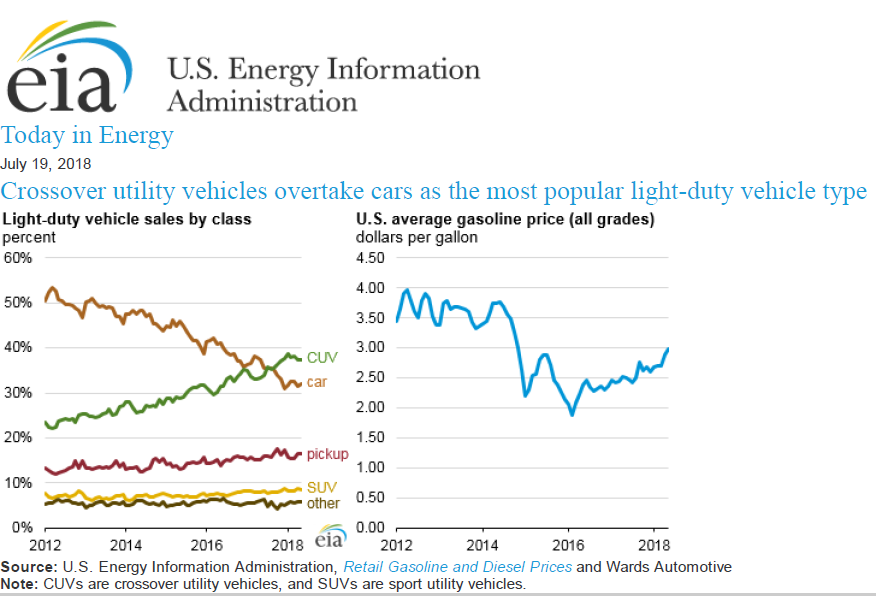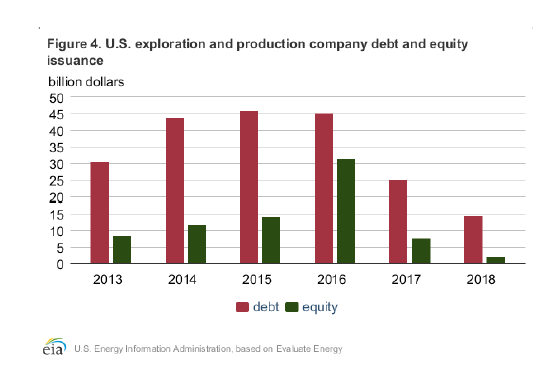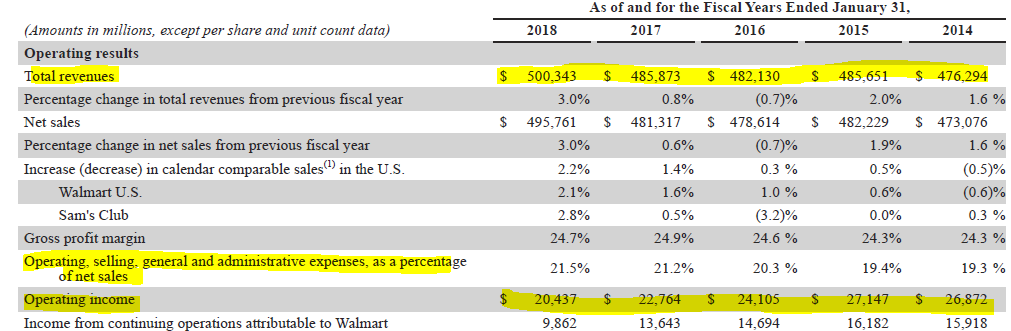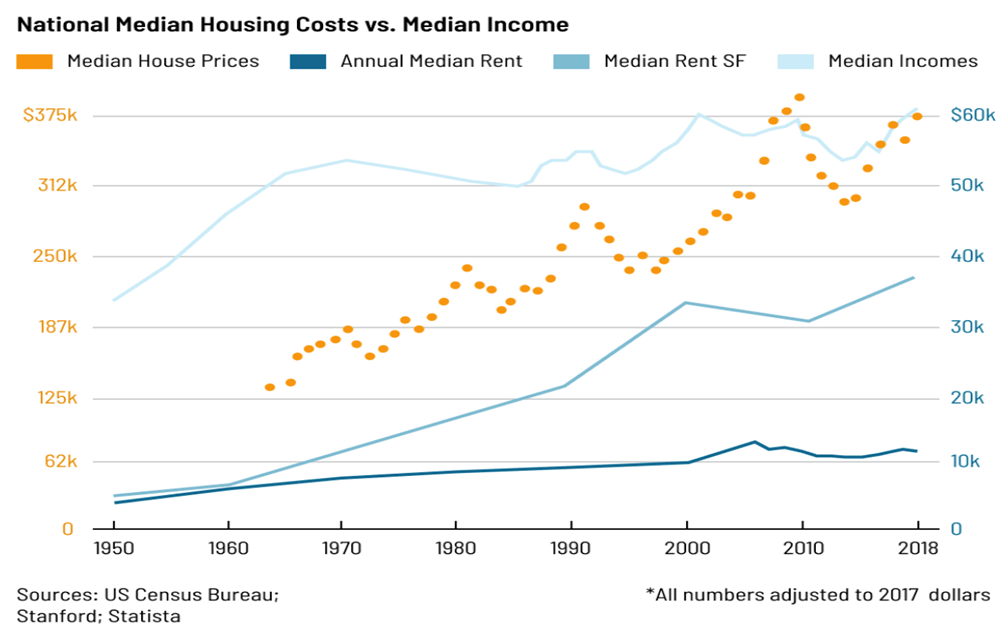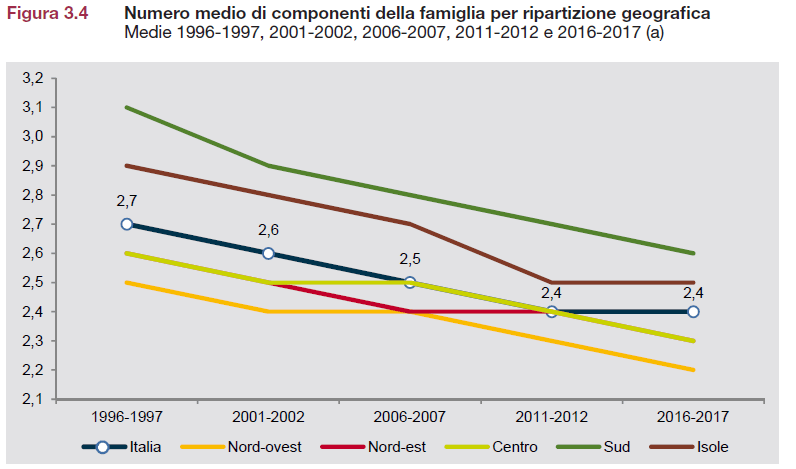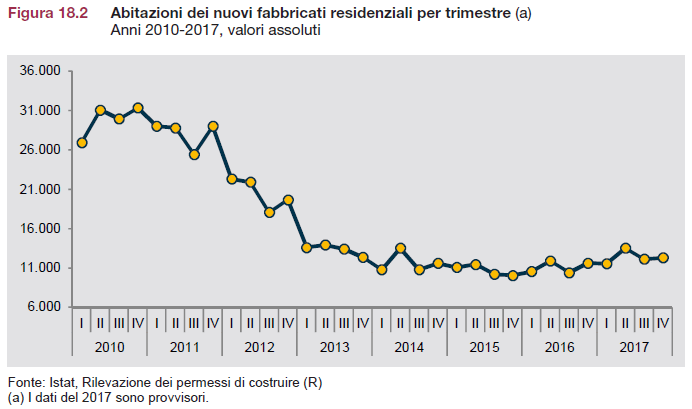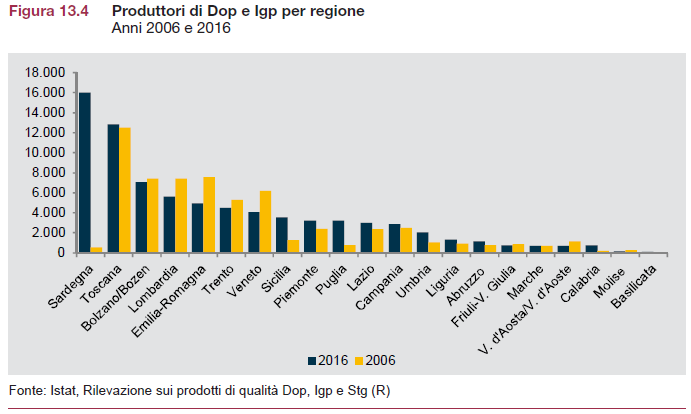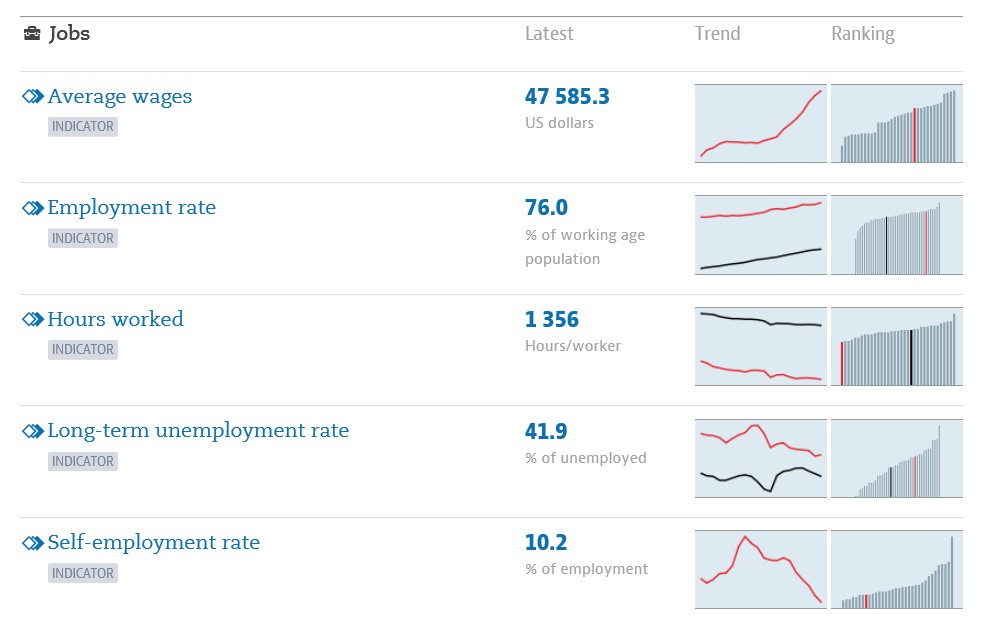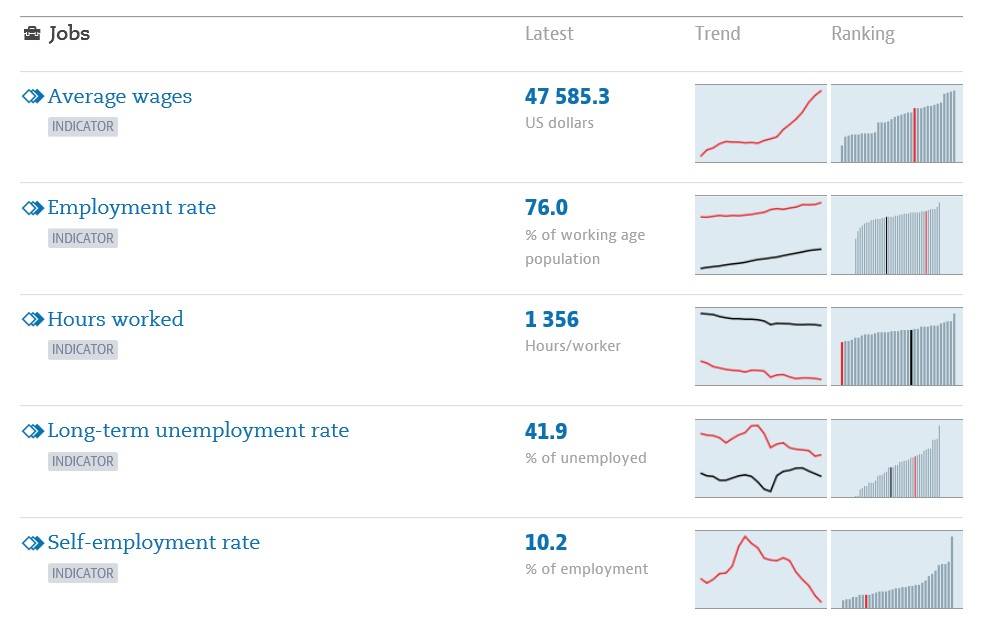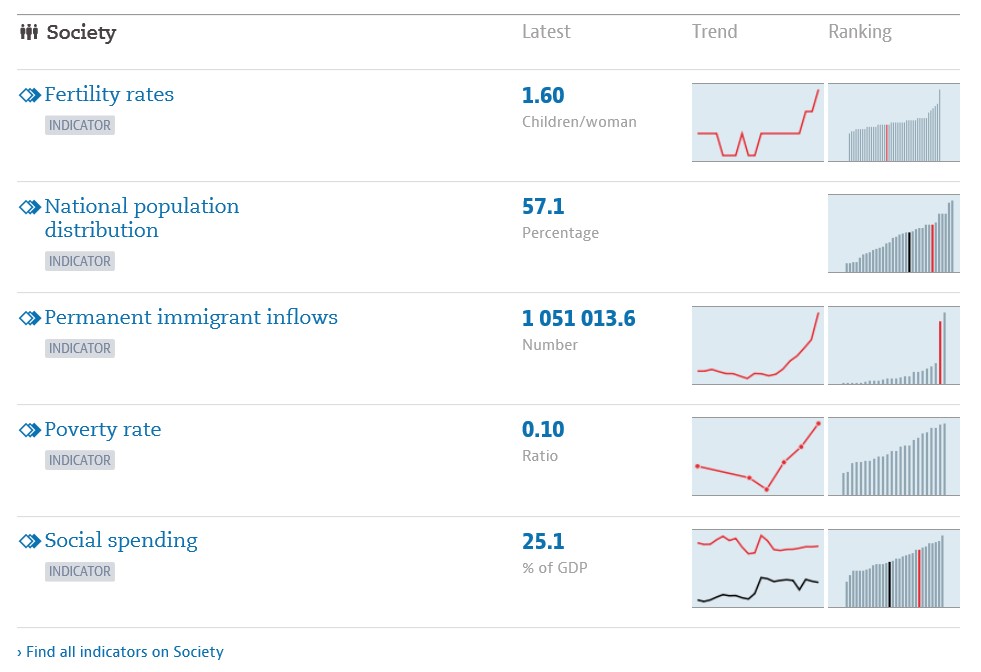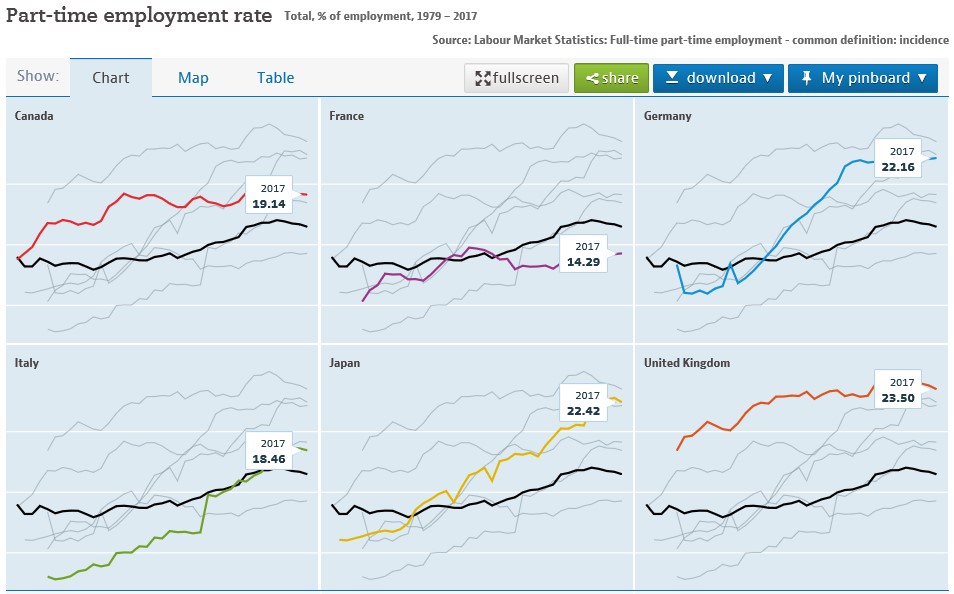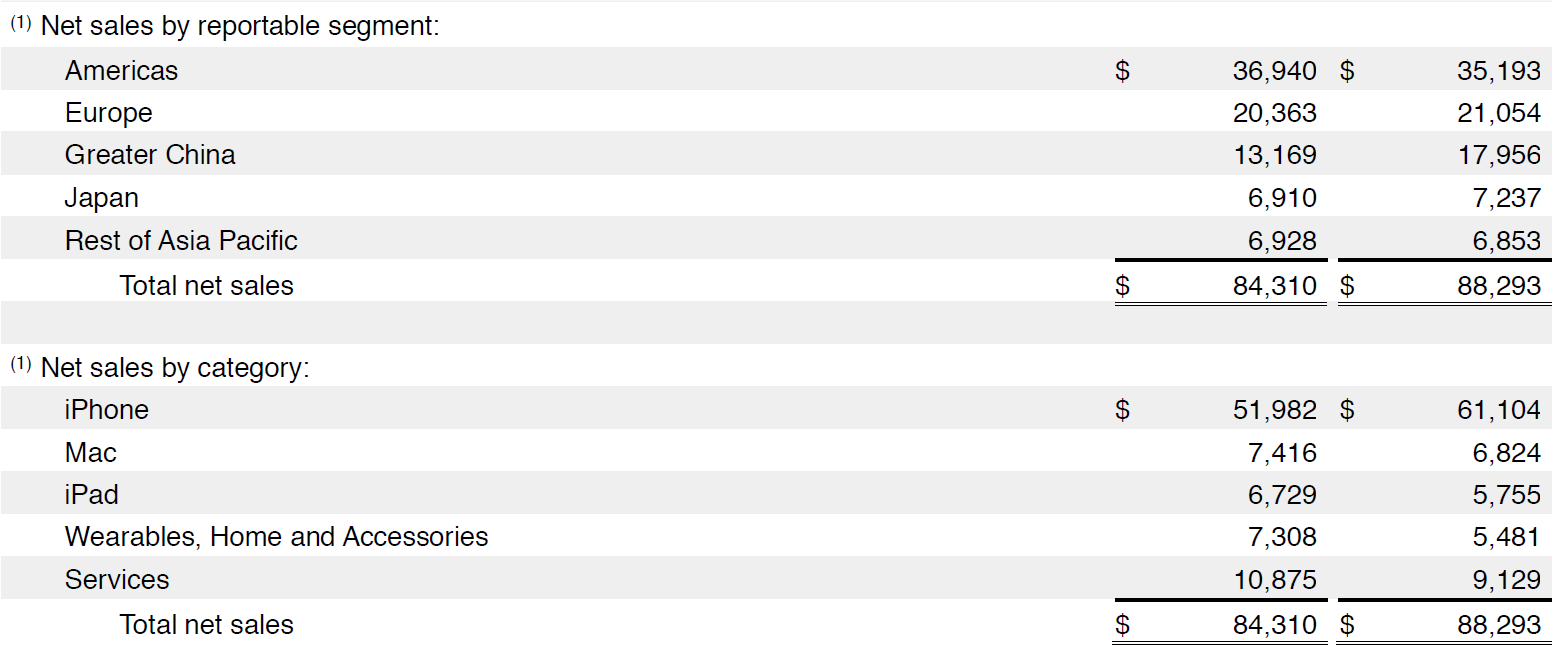Cari lettori di neON e-non, qui un pezzo dell’analisi pubblicata sul blog Econopoly IlSole24Ore.
Ogni giorno acquistiamo prodotti che hanno un impatto sul nostro pianeta. Catene di approvvigionamento opache, ambienti devastanti che compromettono il benessere di persone, animali e comunità. Raramente disponiamo delle informazioni necessarie per fare scelte positive su cosa acquistare.
A quanto pare è Il pesce il settore alimentare ad essere più vulnerabile alle contraffazioni su larga scala. In una delle ultime note del 2018 l’agenzia Europol mostra i dettagli dell’operazione Tarantelo. Un’operazione coordinata dalla Guardia Civil sul pesce venduto illegalmente in Spagna. Pesce che veniva importato attraverso i porti francesi, dopo essere stato catturato nelle acque italiane e maltesi.
Leggiamo nella nota che le frodi più diffuse riguardano la sostituzione o errata etichettatura. Ad esempio merci etichettate come legali quando in realtà non lo sono oppure pesce di allevamento venduto come pescato.
Circa il 20% dei test fatti sulla vendita al dettaglio e ristorazione riguardo ai frutti di mare sono erroneamente etichettati. Un pericolo per la salute pubblica. Nel giugno 2018 fu smantellata un’organizzazione internazionale che gestiva più di 2.000 tonnellate di tonno all’anno. Si trattava di pesce non congelato adeguatamente, trattato con coloranti e venduto come fresco.
Oltre al commercio di merce “non in regola”, le organizzazioni criminali riescono soprattutto a riciclare denaro. Insomma ci guadagnano due volte lungo la filiera, a monte e a valle.
Supply Chain – La Filiera
Il crimine è coinvolto in tutta la filiera su scala internazionale. Dalla pesca a strascico fino al controllo in alcuni casi, dei mercati e dei punti finali di vendita. Magari anche il vostro ristorante di fiducia.
Su scala globale sta emergendo una nuova pratica terrificante: uomini trattenuti su barche, contro la loro volontà, per lavorare circa 20 ore al giorno. Qualcuno purtroppo non torna a terra.
Nel 2015 il Regno Unito ha approvato (il primo) Modern Slavery Act. Richiede alle aziende che fanno affari nel Regno Unito con oltre 36 milioni di sterline in fatturato, di riportare pubblicamente i loro sforzi volti a garantire che le loro filiere siano libere da abusi e, in generale, da casi di lavoro forzato. Anche il governo australiano si sta muovendo in tal senso.
La tecnologia può aiutare molto, anche con le immagini satellitari: ne ho parlato qui su Econopoly. Ma soprattutto sul discorso filiera abbiamo la blockchain che potrebbe fare la differenza: ad esempio la startup Provenance (in italiano vuol dire Provenienza) con sede a Londra, è nata pochi anni fa proprio per occuparsi della filiera di produzione del tonno in Indonesia. È una piattaforma digitale che consente ai marchi di compiere passi verso una maggiore trasparenza. Secondo quanto riportato sul loro sito, il loro software permetterebbe alle aziende di raccogliere e presentare informazioni e storie sui prodotti e le loro catene di approvvigionamento. Ovviamente tutto supportato da dati. Collegando le informazioni ai prodotti in negozio, al pacco e al mercato online potrete scoprirne l’origine.
Concludendo
Migliorare il livello di informazione può consentire una scelta più consapevole.
Fornire cibo e mezzi di sussistenza ad una popolazione di ben oltre 9 miliardi non è semplice. La produzione di pesce nel 2016 ha raggiunto il massimo storico di 171 milioni di tonnellate, di cui l’88% utilizzato per il consumo umano. Un record nel consumo pro capite di 20,3 kg nel 2016.
Una grande sfida, senza alcun dubbio. Ma questo non vuol dire che non possiamo farlo in maniera più equa e responsabile.

<